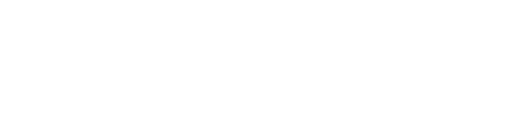Concelebrare
«… SOCIA EXULTATIONE CONCELEBRANT»
Il verbo concelebrare, di normale uso liturgico, si adopera per la Messa quando più sacerdoti la celebrano attorno al medesimo altare. Lo si prende nel senso di “celebrare insieme”. La concelebrazione ha origini antiche, ma si è differenziata nei secoli. L’Ordo Romanuns I (sec. VIII) documenta una concelebrazione solo cerimoniale, nella quale il solo presidente pronuncia le parole istitutive dell’Eucaristia, mentre i sacerdoti a latere stendono le mani verso pane e vino al momento di invocazione (=epiclesi) dello Spirito Santo, perché faccia il suo dovere. Nessuno di loro si sognava di dire che non avesse celebrato, solo perché rimasto muto come un pesce. Nel corso dei secoli la concelebrazione, peraltro mai chiamata così, si eclissò, resistendo solo nel rito di ordinazione sacerdotale in una forma capovolta rispetto alla primitive usanze: tutti i concelebranti dicevano tutto in contemporanea. La potremmo chiamare concelebrazione corale. La riforma del Vaticano II ha rilanciato la concelebrazione con un ragionevole dosaggio del parlato corale. E’ forse un po’ sfuggita di mano, dando luogo a concelebrazioni oceaniche, tipo quelle che si vedono nelle “piazzate pontificie”…
Il Messale Romano, nel disciplinare la concelebrazione princeps che è quella della Missa chrismatis, ha in mente una partecipazione non di tutti i preti della diocesi, ma per delegazioni zonali: quanto basta per rappresentare l’unità del presbiterio diocesano. La stessa cautela è confermata nella terza edizione latina (anno 2002). L’intenzione è probabilmente quella di evitare affollamenti clericali che allontanino troppo i concelebranti dall’altare; e di evitare nella recita corale schiamazzi liturgici alla “profeti di Baal” (cfr 1 Re 18,25- 29). Vista la catastrofica diminuzione del clero, questo è un rischio che si corre sempre di meno.
Fatte queste premesse di ambientamento, mi soffermo un attimo sul verbo latino “concelebrare” ormai di casa nel gergo liturgico, per indicare ciò che sopra ho raccontato. Da questo verbo clona il sostantivo concelebratio, ignoto alla classicità, e il participio sostantivato concelebrans per indicare rispettivamente l’atto del concelebrare e i singoli sacerdoti coinvolti. Il verbo concelebro e derivati è molto ricorrente nei Praenotanda del Missale Romanum, laddove è disciplinata la concelebrazione (De Missa concelebrata nn. 199-251). Nell’eucologia, che è la polpa del Messale, invece compare solo il verbo, senza derivati, nella forma concelebrant, avendo come soggetto i cori angelici, nel sintagma prefaziale «… beata Seraphim, socia exultatione concelebrant». E’ peraltro ricorrenza assai rara: solo cinque volte in tutto il Messale.
Si ritiene che il modo di concelebrare dei concelebrati celesti sia diverso da quello dei concelebranti terrestri. L’eucologia dà al verbo in questione un altro significato, non tecnico, ma usuale nella latinità classica, ove assume il valore più squillante di “frequentare”, “affollare”; producendo dunque l’idea biblica (Dn 7,10) di sterminate folle angeliche che fanno corte “all’Antico di giorni” (ivi 7,9.13). Folle contemplate anche da Dante che, rinunciando a ogni calcolo, si limita a dire che il loro numero si “immilla”(Paradiso XXVIII 93), ossia quelle creature superne si moltiplicano per mille, come i cinesi. Il verbo concelebro possiede comunque una sua arcaica connotazione sacrale, tanto da comparire in apertura (I 4) del De Rerum Natura di Lucrezio – avendo come soggetto nientemeno che la dea Venere (Aeneadum genetrix = madre degli Eneadi: questi cotali sono i romani) – nel senso di “frequentare gioiosamente, con vitalità”. Il sacro indotto da Venere, non particolarmente casta, sarà pur stato un po’ in tono minore rispetto al sacro biblico, ma sempre di sacro si tratta. In questo caso un sacro naturalistico, in quanto Venere, dea dell’amore, è salutata e festeggiata come artefice di vita, perché rende feconda la terra, in qualche modo da lei permeata.
Nel latino della normativa liturgica il verbo concelebrare, così vitalizzato e festoso quando brandito da Venere e Angeli, si svigorisce, divenendo apatica formula denotante compresenza di più ministri attorno al medesimo altare. Ma è stato comodo e spontaneo: se il verbo tradizionale per l’atto di “dire Messa” è celebrare, quando la Messa è detta da più, che poteva esserci di meglio di “concelebrare”?
«ASCOLTACI, O SIGNORE»
La liturgia, pur essendo rigorosamente codificata, consente talora invitanti margini di manovra, nei quali l’assemblea orante si può esprimere con disciplinata libertà. Sto pensando alla Preghiera dei fedeli, per la quale non esistono testi ufficiali. Non lo è neppure l’Orazionale annesso al Messale, come volumetto indipendente. I non eccelsi formulari dell’Orazionale hanno solo la pretesa di essere dei facsimile, destinati a eccitare l’inventiva locale. Più che come facsimile preferisco pensarli come dei fac-aliter (= fa’ altrimenti), perché li trovo obesi e verbosi, lontani dalla parsimonia di linguaggio che è il riconosciuto genio della liturgia romana, apprezzabile soprattutto in latino. Ma perché non dovrebbe esserlo anche in italiano? Un altro limite stilistico è la presenza di undici formulari – su circa centoventi – con le intenzioni rivolte direttamente a Dio in seconda persona grammaticale. La proporzione numerica non è enorme e l’accennato orientamento locutorio è ben lontano dall’eresia. Ma la liturgia ha un suo galateo, sussiegosamente austero, che è bene rispettare.
Una regola liturgica, non codificata ma tradizionalmente rispettata, vuole che a Dio direttamente si rivolgano l’assemblea al gran completo (si pensi al Gloria) e il celebrante quando prega a nome di lei in prima persona plurale. Al lettore della prece dei fedeli è stilisticamente negato questo ardire, onde si deve esternare con formula aggirante: non dunque «Ti preghiamo, Signore, perché bla-bla-bla», ma «Perché il Signore bla-bla-bla, preghiamo».
Purtroppo questa atteggiamento confidenziale si è largamente travasato nel nuovo Rito delle Esequie (ed. 2010). In esso quasi tutti i formulari di preghiera dei fedeli aggiunti dalla Conferenza Episcopale Italiana schiaffano il lettore davanti a Dio a colloquiare direttamente con Lui. Ne cito un’intenzione a casaccio (p. 293):
Padre buono e fedele,il nostro fratello N.nella sua lunga esistenza terrena si è sempre affidato a te, credendo e sperandonella vita eterna;ora accoglilotra le tue braccia paternee donagli la graziadi cantare in eterno il tuo amore.
E’ stonato l’orientamento orante, come si è detto, e per giunta il testo e pletorico. Al defunto si fa persino un mini-panegirico, assai rischioso («il nostro fratello … nella vita eterna») perché può anche darsi che non sia stato propriamente così. Avrei preferito che il concetto, peraltro bello, fosse espresso con più prudenza e con più controllo orante:
Perché il nostro fratello N., che ha cercatodi esserti gradito in questa vita, sia accolto da Dioe canti in eterno il suo amore, preghiamo.
Le parole sono lesinate: 26 invece di 43, con guadagno in termini di sobrietà. Inoltre si atterra sul preghiamo. Se non si finisce col preghiamo, che l’assemblea si aspetta, non scroscia la risposta «Ascoltaci, Signore». Ma grazie all’elasticità che tali testi consentono, non è vietato riformulare. Non sono formule ne
varientur, ma suggerimenti di preghiera da trattarsi con disciplinata libertà.