XXXIV domenica del Tempo ordinario
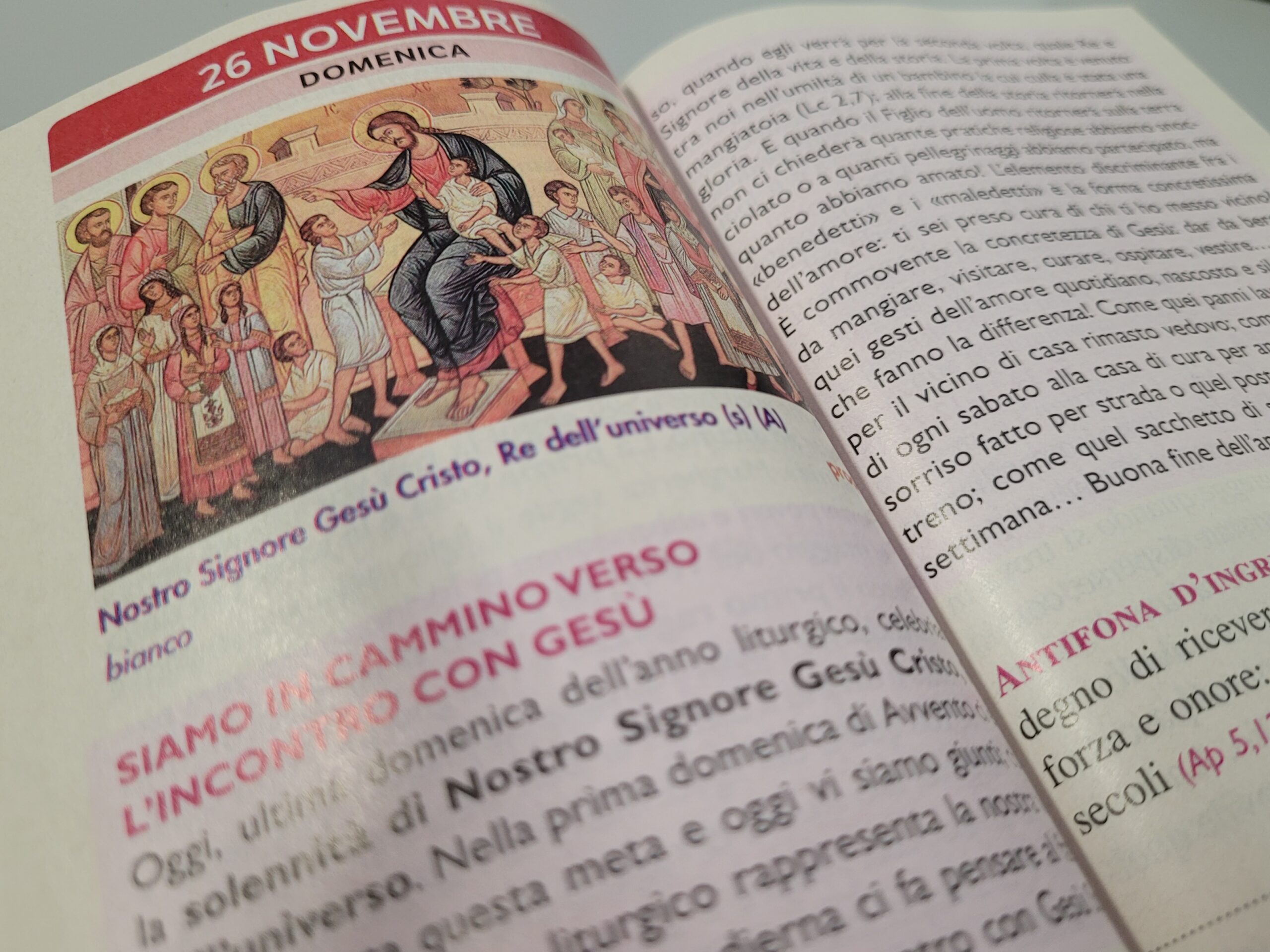
A cura della Fraternità della Trasfigurazione
In occasione della solennità di Cristo Re la liturgia propone la parabola del giudizio finale. Lo stile apocalittico del testo – la venuta del Figlio dell’uomo insieme agli angeli, il raduno di tutti i popoli, l’atto di separare capri e pecore, la presenza del trono -, ma soprattutto le sue rappresentazioni artistiche, in primo luogo l’affresco della Cappella Sistina, ne hanno favorito una lettura distorta privandolo della sua bellezza. Soffermiamoci allora a osservare questo re, le sue azioni e le parole che pronuncia. Egli, innanzitutto, non è solo un giudice ma è anche un pastore, qualcuno che ha cura e si fa carico del suo gregge. Numerosi sono i testi biblici che si potrebbero citare per mettere in risalto come il pastore si prende a cuore le pecore che gli sono affidate. Il fatto che egli le separi dai capri riflette quanto avviene normalmente nell’ovile al sopraggiungere della notte. Nel nostro testo questo atto esprime anche il giudizio che il re opera su coloro che già si definiscono come capri o pecore. Non sono infatti le predisposizioni o le preferenze del re a renderli tali e nemmeno il suo giudizio, ma il modo in cui essi hanno vissuto. Cogliamo così nella parabola un invito ad assumere le proprie responsabilità nei confronti dell’esistenza, perché sarà il nostro modo di vivere e non il suo giudizio a collocarci alla sua destra o alla sua sinistra. L’ascolto delle parole del re aiuta a meglio comprendere quale sia il criterio in base al quale si opera il suo discernimento: il bene operato nei confronti dell’altro in difficoltà. Non un criterio religioso – la preghiera, la pratica dei sacramenti, aspetti comunque essenziali dell’esistenza cristiana – ma profano, basato su comportamenti che ogni uomo dal cuore buono, non indurito, può fare suoi. La volontà di salvezza di questo re è davvero infinita: egli ci chiede semplicemente di essere umani e, proprio perché umani, aperti all’altro, empatici, compassionevoli, non solo con le parole ma soprattutto con gli atti. Anche il discorso che il re-giudice rivolge alle pecore ne manifesta la magnanimità e anche la divinità; quale re, infatti, sarebbe disposto a dare in eredità il suo regno e a condividerlo con i suoi sudditi? Solo Colui che ha dato la vita per “riunire i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,51). E quale persona chiamata a esercitare una tale autorità è talmente attenta ai piccoli, ai fragili, ai deboli da identificarsi così profondamente con loro fino a considerare come fatto a sé il bene che essi hanno ricevuto? C’è un’eccedenza d’amore in questa parabola che, invece di farci temere, dovrebbe aprire il cuore alla speranza. E coloro che sono condannati al supplizio eterno? Una lettura attenta del testo permette di constatare come più che le persone siano gli atti, o piuttosto la mancanza di atti a favore del fratello, l’oggetto della condanna da parte di Gesù. Per tale motivo osiamo sperare che non si trovi nessuno il cui rifiuto nei confronti dell’altro sia stato totale e a ogni uomo sia concessa la dolce e gioiosa esperienza di sentire anche rivolto a sé l’invito: “Vieni, benedetto dal Padre mio”.
